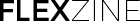Nata nel 1984 a New York da genitori israeliani, Ruth Patir è cresciuta a Tel Aviv. Ha conseguito il Diploma in Belle Arti alla Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme nel 2011, poi un Master of Fine Arts in “New Genres” presso la Columbia University di New York nel 2015. Attualmente residente a Tel Aviv, l’artista insegna alla Bezalel Academy e alla Sapir Academic University. È nota per il suo lavoro su un’ampia gamma di temi, che vanno dall’esperienza personale a tematiche sociali più ampie come le questioni di genere, la tecnologia e i meccanismi nascosti del potere.
Ruth Patir esplora le possibilità creative del realismo attraverso la fusione di cinema documentario e computer grafica. Tra le sue mostre, ricordiamo: “My Father in the Cloud” al CCA di Tel Aviv (2022), “M/otherland” presso il OnCurating Project Space di Zurigo (2021) e “Love Letters to Ruth” alla Hamidrasha Gallery di Tel Aviv (2018). Le sue opere sono conservate in prestigiosi musei, tra cui il Tel Aviv Museum of Art, l’Israel Museum di Gerusalemme, il Centre Pompidou e la KADIST Foundation di Parigi.
I suoi video sono stati presentati al MoMA di New York e al Jerusalem Film Festival. Il suo film “Sleepers” ha ricevuto il “Video and Experimental Cinema and Video Art Award” al Jerusalem Film Festival nel 2018.

Wakapedia’s Ruth Patir & Israeli Pavilion
La notizia aveva suscitato scalpore mediatico e aperto il dibattito, non solo nella cerchia ristretta dell’arte contemporanea, ma anche sulle maggiori testate internazionali: nel febbraio 2024, il gruppo Art Not Genocide Alliance aveva lanciato una petizione chiedendo agli organizzatori della Biennale di Venezia l’esclusione di Israele da questa 60a edizione a causa delle «atrocità in corso contro i Palestinesi a Gaza». In risposta a questo testo – firmato da quasi 24.000 attori del mondo della cultura, tra cui la fotografa americana Nan Goldin e l’artista britannico Jesse Darling (Turner Prize 2023) – l’artista israeliana Ruth Patir e le due co-curatrici del padiglione avevano inizialmente difeso la loro libertà di esporre, sottolineando la loro dissociazione dalle azioni e dalla comunicazione del Governo israeliano. Ma alla fine, pochi giorni prima dell’apertura ufficiale della Biennale, Ruth Patir aveva deciso che la sua mostra (M)otherland non avrebbe aperto al pubblico, fino a quando non sarebbe stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.
Anche noi di Wakapedia avevamo seguito con interesse questa vicenda e appreso con rammarico la mancata apertura del padiglione Israele. In effetti, eravamo molto curiose di visitare la mostra (M)otherland che affronta un tema che ci tocca da vicino, quello della fertilità femminile e del congelamento degli ovociti. Ci sarebbe piaciuto discuterne con l’artista, ma eravamo ormai rassegnate all’idea che non sarebbe mai stato possibile in questo contesto… Ma – e questo è un po’ il filo conduttore nella storia di Wakapedia – a volte le cose accadono attraverso incontri casuali e sorprendenti! A giugno, siamo tornate a Venezia per visitare il padiglione vaticano installato nella Casa di reclusione femminile della Giudecca. Tra i vari artisti esposti c’era il nostro amato Maurizio Cattelan, da brave groupies non potevamo perdercelo! Purtroppo, a volte siamo groupies un po’ svampite e, accecate dall’entusiasmo e dall’amore per… l’arte, ci eravamo dimenticate di prenotare online. Ci siamo quindi ritrovate in coda all’entrata, ed è allora che è entrata in azione la Dea del Destino che veglia su Wakapedia e che trasforma i nostri errori in miracoli! Tra gli altri visitatori in attesa, abbiamo incontrato Udi Edelman, un uomo molto gentile, stanco come noi di aspettare sotto il sole cocente. Appassionate d’arte certo, ma ancor più allergiche ai colpi di sole, gli abbiamo proposto di andare a bere un cocktail fresco in un bar in zona. E sorseggiando il nostro Bellini all’Harry’s Bar (proprio là dove è stato inventato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, ndr), abbiamo scoperto che Udi era nintepopodimeno che… un conoscente degli organizzatori del padiglione Israele! Grazie a lui abbiamo potuto contattare Ruth Patir e realizzare la seguente intervista.
La morale della storia? Carpe diem e credici sempre!

1. Buongiorno Ruth, siamo estremamente grate di poterla intervistare e conoscerla meglio. Ci parli della sua infanzia e di come è diventata un’artista. Ci racconti qualche evento che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.
Sono cresciuta a Tel Aviv negli anni Novanta. Entrambi i miei genitori erano ingegneri, non ho ricevuto un’educazione artistica da loro, ma poiché lavoravano molto, passavo il pomeriggio a seguire le lezioni al museo di Tel Aviv. Per mia madre e mio padre era un semplice passatempo, non immaginavano che sarei diventata un’artista, anzi, ma è proprio lì che mi sono innamorata dell’arte. Poi però ho avuto una sorta di crisi esistenziale a 14 anni; feci sedere mia madre e la informai che non avrei più dipinto (!). Mi sono resa conto che lo stavo facendo solo per attirare la sua attenzione. Smisi davvero e buttai via tutti i miei materiali, è stato tutto molto teatrale. Feci passare molti anni, forse dieci, poi capii che la pittura mi mancava troppo. È stato allora che mi sono iscritta al corso di laurea triennale in Belle Arti alla Bezalel Academy di Gerusalemme, l’accademia dove ora insegno.
2. Il tema di questa Biennale è “Stranieri ovunque”. Lei stessa ha lasciato Israele per gli Stati Uniti e come “straniera” ha conseguito un Master in Nuovi Generi Artistici alla Columbia University. Come ha vissuto questa esperienza? E come ha influenzato la sua arte?
Prima di venire a studiare in America, pensavo di essere una cittadina del mondo. Pensavo che il mio inglese (imparato guardando la televisione americana in Israele) fosse impeccabile, così buono da farmi sentire a mio agio in ogni ambito. Solo arrivando in America ho capito cosa si prova davvero a essere uno straniero; c’è questa sensazione di mancanza di casa da cui non sarei più riuscita a sfuggire. Gli Americani sono dei gran lavoratori ed estremamente identitari, è molto stimolante. Essere un’immigrata mi ha insegnato molta umiltà e anche a lavorare di più. Credo di aver imparato a condividere la mia vulnerabilità con il pubblico. Sono davvero grata per l’opportunità di essere stata lì quando ne ho avuto la possibilità, ma non vedevo l’ora di tornare a casa.

3. Ha deciso di non aprire il padiglione Israele alla Biennale 2024. Quali fattori – sia esterni che personali – hanno influito su questa sua decisione?
Sono stata nominata artista del padiglione Israele alla 20a Biennale Arte di Venezia, il 7 settembre 2023; ero molto emozionata, perché volevo realizzare questo progetto da diversi anni. La mia eccitazione è calata rapidamente, in seguito alle devastanti conseguenze del 7 ottobre e del conflitto atroce che ne è seguito.
Con il passare dei giorni, io e le mie curatrici Mira Lapidot e Tamar Margalith abbiamo lottato con l’idea di agire come se nulla fosse cambiato e abbiamo partecipato a manifestazioni settimanali contro la guerra. Dato che la situazione era molto instabile, abbiamo deciso di fare un aggiornamento settimanale, convinte che entro aprile la nostra realtà sarebbe cambiata, in meglio. Purtroppo, la tragedia non ha fatto che peggiorare. La nostra decisione è diventata chiara nei giorni dell’allestimento, poiché sentivamo, in tutta coscienza, che non potevamo agire come se nulla fosse.
Così abbiamo deciso di allestire la mostra, per non annullare il nostro lavoro, ma di tenerla in pausa. Abbiamo appeso all’entrata un semplice cartello che diceva: “L’artista e i curatori del padiglione israeliano apriranno la mostra una volta raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”. Speravamo, così facendo, che la gente aspettasse con noi: la mostra è lì, pronta, ma aspetta che la realtà esterna cambi in meglio per essere visitata dal pubblico. Da allora, purtroppo, non è cambiato molto. Ma mi conforta il fatto che, quando le persone desiderano che le porte del padiglione si aprano, pregano anche con me per il cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi. In questa duplice preghiera, abbiamo unito la nostra voce a quella dei manifestanti della mia città, Tel Aviv, nel loro grido per un cambiamento.

4. Perché ha scelto l’opera (M)otherland e la maternità come tema? Oltre ad aver congelato i suoi ovuli, ci sono stati altri eventi che l’hanno ispirata?
Uno degli aspetti biopolitici più significativi dello Stato di Israele è la sua ossessione nazionale per la fertilità. È curioso notare che Israele è uno dei pochi paesi al mondo che sovvenziona il congelamento degli ovuli. Lo Stato raccomanda ufficialmente alle donne non sposate di età superiore ai 30 anni di considerare questa opzione. Mentre nella maggior parte dei paesi il congelamento degli ovuli è un processo molto costoso, riservato a persone abbienti, in Israele è abbastanza comune e largamente discusso. Questo crea un collegamento molto evidente tra l’ideologia di popolare lo Stato con bambini ebrei e i diritti riproduttivi.
Nel 2019, mi è stata diagnosticata una mutazione genetica che aumenta significativamente le probabilità di sviluppare il cancro agli organi riproduttivi in giovane età. Per precauzione, mi è stato consigliato di rimuovere questi organi, ma prima di farlo, di usufruire dei trattamenti di fertilità, completamente finanziati dallo Stato d’Israele. Ero, e sono tuttora, single e incerta sul desiderio di diventare madre, ma in Israele questa sembra essere una decisione difficile da accettare per molti. Perciò il titolo che ho scelto, che aggiunge la parola “other” (altro) a “Motherland” (Madrepatria, il nome con cui gli ebrei di tutto il mondo si riferiscono allo Stato di Israele), mi è sembrato molto appropriato per quest’opera.
5. Lei dice che la sua opera per il padiglione Israele è stata concepita e finalizzata nei mesi scorsi, dopo i brutali attacchi del 7 ottobre e il conflitto tra Israele e Hamas che ancora infuria. Che impatto ha avuto questa situazione sulle sue opere?
In questo progetto utilizzo tecnologie nuove che sono centrali nella mia pratica: l’animazione 3D e soprattutto la motion capture, con tute apposite per la cattura del movimento. Mi riprendo mentre indosso la tuta e utilizzo la registrazione del mio corpo per dare vita a reliquie di culture antiche, con l’intento di creare un ponte tra il presente e il passato.
All’indomani dello scoppio del conflitto, dopo lo shock iniziale, ho montato il film principale (M)otherland, una docu-animazione di 30 minuti, e ho deciso di aggiungere alcune nuove opere alla mostra, soprattutto Keening, un breve film di animazione ambientato ai giorni nostri.
Volevo che lo spettatore entrasse nello spazio con lo stesso stato emotivo in cui mi trovavo: un mix di dolore e rabbia. L’opera trae ispirazione dalla tradizione del Keening, che risale a 4000 anni fa nella cultura mesopotamica, ma che è ancora presente oggi in alcuni Paesi. Il Keening è una pratica femminile, in cui le donne piangono insieme. Si dice che piangendo e urlando creino un nido dove il dolore si possa depositare.
Il film è anche stato realizzato con la tecnologia del motion capture, animando frammenti di statuette femminili risalenti al 600-800 a.C. ritrovate nella nostra regione. Questi frammenti, pezzi rotti di donne intere, mi sono sembrati ben rappresentare la violenza che le donne hanno subito e continuano a subire nella regione israelo-palestinese, una tragedia senza tempo e senza fine. E poiché queste statuette sono antecedenti al monoteismo, spero possano rappresentare le donne di entrambe le parti. O come le abbiamo descritte: «Donne abbandonate di una civiltà passata, le statuette di (M)otherland ci raggiungono attraverso il tempo, intere o in frantumi, come resti di spargimenti di sangue e guerre che evocano l’esperienza intrecciata della femminilità, della rottura e del lutto collettivo».
6. Come donna che ha congelato i propri ovuli, c’è un messaggio che vorrebbe trasmettere alle altre donne? Il congelamento degli ovuli l’ha cambiata in qualche modo?
Vorrei solo dire che credo sia necessario parlarne. Tradizionalmente e ancora oggi la maggior parte dei progressi scientifici legati alla procreazione sono stati inventati per il bene delle donne, ma a volte non tengono conto del punto di vista femminile. Prendiamo la pillola: è, certo, una rivoluzione per i diritti delle donne, ma anche uno strumento che le rende le uniche responsabili della contraccezione. Oggigiorno, potremmo dire che l’equivalente del diritto alla contraccezione di 50 anni fa, è il diritto alla preservazione della fertilità, cioè il congelamento degli ovuli. Quest’ultimo, da un lato permette alle donne con problemi di salute di concepire, il che è straordinario, dall’altro consente alle donne di posticipare la loro finestra di fertilità in modo da potersi prima dedicare agli studi e alla carriera; tutte cose piuttosto positive. Ma, quando ci riflettiamo meglio, questo dispositivo incentiva in sostanza le donne a essere più simili agli uomini, invece di permettere loro di pensare alla maternità come a un tipo di lavoro integrato e valorizzato dalla società. Secondo me, invece di dare alle donne più opzioni, l’egg freezing è un’ulteriore fonte di pressione per procreare e allo stesso tempo essere donne in carriera di successo, bloccandole ancora in un ordine patriarcale che stabilisce cosa è giusto e migliore per loro.
Edited by: Federica Forte